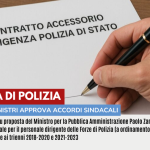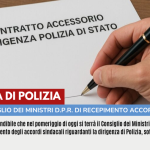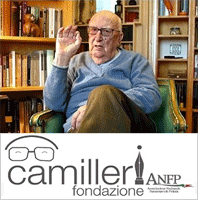EDITORIALE: TRA PISTOLA E CONTATTO FISICO, IL TASER E’ UNO STRUMENTO NECESSARIO


Negli ultimi giorni l’opinione pubblica è stata scossa da due tragici eventi: i decessi di Olbia e di Genova, avvenuti dopo l’impiego del Taser da parte delle forze dell’ordine. Come sempre accade in casi simili, le emozioni hanno preso il sopravvento e il dibattito si è acceso, talvolta in maniera superficiale o ideologica. Va detto, altresì, che il perito del tribunale per il caso di Olbia ha escluso che la causa della morte possa essere stato l’uso del Taser. È quindi doveroso affrontare il tema con equilibrio, partendo da una domanda chiara: perché lo Stato ha deciso di introdurre il Taser in dotazione alle forze di polizia?
La risposta sta nella sua funzione tecnica: il Taser è uno strumento di contenimento non letale, pensato per permettere agli operatori di interrompere condotte violente o pericolose senza dover ricorrere ad armi tradizionalmente più traumatiche. È uno strumento “intermedio”, che si colloca tra la persuasione verbale e la pistola d’ordinanza, e che in moltissimi casi ha consentito di bloccare soggetti in forte stato di alterazione senza gravi conseguenze.
Tuttavia, come ogni tecnologia, anche il Taser ha limiti operativi che non possono essere ignorati. In alcuni casi l’effetto è parziale, temporaneo o del tutto assente. Emblematico l’episodio di Milano Lambrate, dove un giovane ispettore fu accoltellato perché la scarica non riuscì a chiudere il circuito elettrico sul giubbotto dell’aggressore. Un mancato effetto che per poco non è costato la vita a un servitore dello Stato.
Vi sono poi aspetti medici che alimentano le polemiche: studi scientifici hanno segnalato possibili interferenze con pacemaker, il rischio di aritmie ventricolari e, in condizioni particolari — agitazione estrema, assunzione di droghe, patologie cardiache pregresse — anche di eventi fatali. Sono rischi reali, che non vanno negati, ma vanno collocati nel giusto contesto: ogni intervento di polizia comporta rischi, anche quando si utilizzano altri strumenti non letali. Lo spray urticante può colpire in modo imprevisto, lo sfollagente può provocare fratture o traumi cranici, persino la semplice immobilizzazione fisica può avere esiti drammatici se la persona cade battendo la testa.
La differenza sostanziale è che il Taser consente all’operatore di mantenere una distanza di sicurezza e di agire con rapidità, riducendo il corpo a corpo — la fase più pericolosa di ogni intervento. È inoltre di facile apprendimento e non richiede anni di addestramento continuo, come invece accade con le tecniche di immobilizzazione. Per questo, a livello operativo, resta lo strumento più equilibrato e pratico oggi a disposizione.
Il vero punto è un altro: non si tratta di esaltare o demonizzare il Taser, ma di valutarlo come parte di un sistema di sicurezza integrato. Occorre ricordare che l’alternativa, spesso taciuta in questo dibattito, non è “Taser o nulla”. Davanti a un aggressore, a volte a mano armata, fuori controllo, sotto effetto di droghe, la vera alternativa è spesso tra Taser e pistola d’ordinanza. E sappiamo bene che l’uso della Beretta calibro 9 ha un’altissima probabilità di esito letale.
In conclusione, discutere del Taser significa affrontare il tema della sicurezza pubblica con realismo. Non è uno strumento perfetto, non è privo di rischi, ma è uno dei mezzi più efficaci per ridurre l’impatto letale degli interventi. L’unico modo serio di parlarne è riconoscere i limiti, pretendere indagini accurate, migliorare costantemente la formazione, e ricordare che dietro a ogni scelta operativa c’è sempre un obiettivo: salvaguardare la vita e la sicurezza di tutti, cittadini e operatori.
Roma, 29 agosto 2025
IL SEGRETARIO NAZIONALE
Enzo Marco Letizia