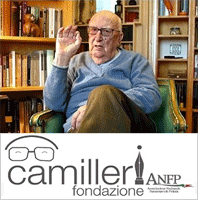ALLA MAFIA PIACEVA UCCIDERE AD AGOSTO
EDITORIALE 8 AGOSTO 2013 – DI ENZO MARCO LETIZIA
Quel 6 agosto 1980, Gaetano Costa salutò la moglie, scese di casa e camminando per la centralissima via Cavour a Palermo, si fermò a sfogliare dei libri a una bancarella come faceva sempre. E fu là che dei killer lo freddarono alle spalle, come in un’esecuzione, lasciandolo dissanguarsi e morire come un animale sul marciapiede.
Dopo 32 anni, sicari e mandanti dell’omicidio del procuratore Costa non hanno ancora un nome. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non sono mai state decisive. La condanna a morte che pesava sulla testa del procuratore Costa, ex partigiano, uomo forte, tenace e equilibrato, l’avevano scritta il superboss Rosario Spatola ed altri 54 mafiosi, cui aveva aperto le porte del carcere. E voleva la sua morte Tano Badalamenti, il boss di Cinisi responsabile dell’omicidio di Peppino Impastato, il giovane militante di Lotta Continua. Ma la sentenza era stata scritta anche da altri insospettabili burattinai: l’aveva detto lui nella sua audizione alla prima Commissione Antimafia, “la mafia in quegli anni aveva subito una radicale mutazione e si era annidata nei gangli vitali della pubblica amministrazione controllandone gli appalti, le assunzioni e la gestione ordinaria”. Si l’avevano pronunciata quegli stessi che dicevano che era un visionario, ossessionato dai fantasmi. E lui inutilmente aveva richiamato l’attenzione delle massime autorità sul fatto che un’efficace lotta alla criminalità organizzata imponeva la predisposizione di strumenti legislativi che consentissero di indagare sui patrimoni dei presunti mafiosi e di colpirli, per arrivare a quei “pupari” seduti molto in alto e ad altre misteriose connivenze.
Di lui scrisse un suo sostituto che era un uomo “di cui si poteva comperare solo la morte”. E pur essendo l’unico magistrato a Palermo al quale erano state assegnate un’auto blindata ed una scorta, non ne usufruiva ritenendo che la sua protezione avrebbe messo in pericolo altri e che lui era uno di quelli che “aveva il dovere di avere coraggio”.
Al funerale parteciparono poche persone, pochi magistrati, pochi cittadini. Sciascia allora profetizzò che sarebbe stato presto dimenticato e che l’oblio fu la seconda condanna a morte di chi l’aveva isolato e additato alla vendetta mafiosa. E Rita Bartoli, moglie del procuratore, in un’intervista rilasciata al ”Corriere della Sera” affermò: “Mio marito fu lasciato solo a firmare i mandati di cattura contro la cosca Spatola-Inzerillo. Qualcuno lo additò addirittura come unico responsabile di quei mandati. Lo andarono a raccontare in giro agli avvocati dei mafiosi, ai giornalisti”.
E ancora un maledetto 6 agosto cinque anni più tardi, in un’altra strada di Palermo due uomini cadono sotto i colpi della mafia come per una terribile coincidenza. Un mese prima, era stato ucciso Piersanti Mattarella, dando inizio a una lunga stagione di sangue che trasformò le strade di Palermo nel teatro di una carneficina.
Anche il dirigente della mobile di Palermo Ninni Cassarà era vicino a casa, stava tornando là, in Viale della Croce Rossa. La moglie lo aspettava, sentì i colpi sparati nell’agguato degli uomini di Cosa Nostra, si affacciò e lo vide morire, insieme all’agente di scorta Roberto Antiochia. A terra, feriti, c’erano gli altri due poliziotti Giovanni Salvatore Lercara e Natale Mondo (che sarà a sua volta ucciso il 14 gennaio 1988). La signora Cassarà gridava, chiedeva soccorso ai vicini, ma nessuno rispose.
Si, sono passati 27 anni dall’omicidio e sono stati condannati gli esecutori e mandanti. Ma restano ancora molti misteri: chi informò il comando di Cosa Nostra che Ninni Cassarà stava tornando a casa? Chi fu la Talpa?
Dopo la morte di Beppe Montana, Cassarà aveva infatti intuito che era nel mirino di Cosa Nostra ed allora aveva deciso di restare anche la notte negli uffici della Squadra Mobile. Quel 6 agosto era quasi una settimana che non tornava a casa.
Quando decide di rischiare per salutare la famiglia e tranquillizzare la moglie e i tre figli, lo aspetta il commando di sicari, come in una tragica sceneggiatura. Arrivato al civico 81 a bordo dell’Alfetta di servizio, scende dall’auto per arrivare al portone della sua abitazione quando un gruppo di nove uomini armati di fucile AK-47, appostati alle finestre e sui piani dell’edificio in costruzione di fronte alla palazzina di casa sua al civico 77, comincia a sparare all’impazzata, non lasciando scampo a lui e all’agente Antiochia.
Era segnato da un destino di morte, Ninni Cassarà. Commissario della Polizia di Stato nella Questura di Reggio Calabria prima e poi a Trapani, dove aveva avuto modo di conoscere Giovanni Falcone. Ne diventa in seguito stretto collaboratore nell’ambito del pool antimafia e le sue indagini contribuiscono all’istruzione del primo maxiprocesso alle cosche mafiose. In forza come vice-questore presso la Questura di Palermo prende parte a numerose operazioni, molte delle quali insieme al commissario Giuseppe Montana, compresa la famose “pizza Connection”, in collaborazione con forze di polizia degli Stati Uniti.
La motivazione della sua medaglia d’oro recita: “Con la piena consapevolezza dei pericoli cui si esponeva, nella lotta contro la feroce organizzazione mafiosa, ispirava, conduceva e sviluppava in prima persona e con eccezionale capacità investigativa una serie di delicate operazioni di polizia giudiziaria che portavano all’identificazione e all’arresto di numerosi fuorilegge. In un proditorio agguato teso davanti alla propria abitazione, veniva colpito da assassini armati di fucili mitragliatori, trovando tragica morte. Alto esempio di attaccamento al dovere spinto fino all’estremo sacrificio della vita”. Il 17 febbraio di dieci anni dopo la terza sezione della Corte l’Assise di Palermo ha condannato all’ergastolo cinque componenti della cupola mafiosa: Totò Riina, Bernardo Provenzano, Bernardo Busca e Francesco Madonia come mandanti del delitto.
Un destino lega Cassarà, Antiochia, Costa, Falcone, Borsellino. Quello di uomini che la paura non riesce a vincere, che la minaccia non sa piegare. Che si conoscono, si stimano, diventano anche amici, se si chiama amicizia quel vincolo fatto di idee affini, di spirito di servizio, stretto in un fato comune che a un certo momento li segna come “morti che camminano”, di condannati cui è concesso l’ultimo desiderio, sfogliare un libro su una bancarella, dare un bacio ai figli, niente di più.
Se ci chiediamo quanto morti la società vorrà avere sulla coscienza, a carico della inadeguatezza di troppi, della scarsa volontà di molti, della correità – ci auguriamo – di pochi, è perché ai molti annunci di fermezza, a successi – nostri – registrati nell’azione di contrasto alle mafie, non corrisponde la determinazione delle istituzioni e della politica a condurre la necessaria lotta senza quartiere, che deve disporre di forze: risorse umane e finanziarie, leggi e tecnologie, irrobustimento delle strutture antimafia, quelle volute e create da Falcone, oggi messe in discussione, rafforzamento degli organismi di controllo che dovrebbero essere operativi per combattere la criminalità economica, ancora più potente in tempi di crisi.
Non ingiuriamo le tante vittime ricordandole con la liturgia degli anniversari. Dimenticarle comporta la sottovalutazione dei loro assassini, oggi ancora e forse più forti e più penetranti se è vero che scorre meno sangue, ma che una escalation potrebbe verificarsi a fini intimidatori, per misurare la proprio potenza, per annichilire il Paese sotto la minaccia di rischi sempre più elevati. Abbiamo imparato che la grande cupola che contribuisce a mettere a repentaglio la sovranità di stati e popoli, che innerva le società, che si insinua ovunque nei gangli vitali, infiltrandosi nell’economia e nel tessuto sociale, è preparata, determinata, poco appariscente e molto influente, in un intreccio di ricchezze, politica, impegnata nella circolazione di denaro, nella penetrazione nel sistema istituzionale, nell’occupazione del territorio, nel monopolio delle grandi opere, nelle infrastrutture e nelle produzioni, preparata, aggiornata evocata a scegliere business “legali”, perché ormai il confine è ormai labile e i profitti più elevati.
Le grandi mafie in grisaglia, professionali, tecnologiche e sofisticate, sono più avanti della polizia, della guardia di finanza, dell’autorità giudiziaria, hanno forse riposto qualche pistola per dedicarsi a operazioni finanziarie e acrobatiche transazioni, poco ostacolate grazie a leggi ad personam, pene miti, condoni e scudi, con imprenditori del crimine in espansione, secondo processi di internazionalizzazione, cosicché la mafia non ha confini né nazionalità.
Dobbiamo essere messi in condizione di combatterli. E potremo vincerli, perché oggi i vicini chiamati a gran voce dalla moglie di Costa accorrerebbero, perché nel nostro Paese sono tanti a tutte le latitudini, parlando tanti dialetti quelli che dicono no, giovani e ragazzi che incontriamo e ci chiedono di noi, del nostro lavoro che è poi un modo di domandare notizie del loro domani. E di ricordare Ninni, il suo agente di scorta, tutti quelli che sono morti per noi, per loro.
Roma, 8 agosto 2013